© 2023 Avv. Prof. Attilio Luigi Maria Toscano - P. IVA 05787940872 - Tutti i diritti riservati
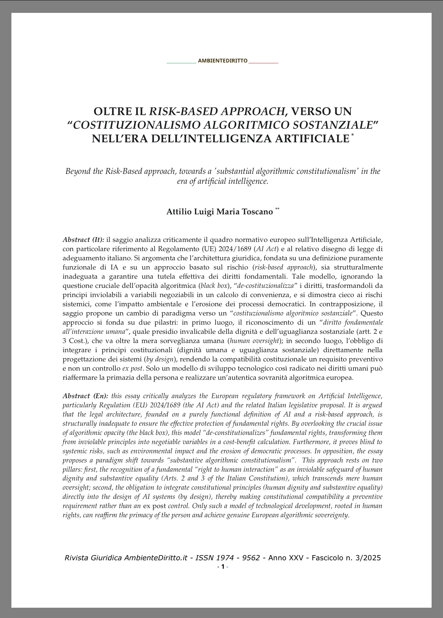
ABSTRACT [IT]: il saggio analizza criticamente il quadro normativo europeo sull’Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) e al relativo disegno di legge di adeguamento italiano. Si argomenta che l’architettura giuridica, fondata su una definizione puramente funzionale di IA e su un approccio basato sul rischio (risk-based approach), sia strutturalmente inadeguata a garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali. Tale modello, ignorando la questione cruciale dell’opacità algoritmica (black box), “de-costituzionalizza” i diritti, trasformandoli da principi inviolabili a variabili negoziabili in un calcolo di convenienza, e si dimostra cieco ai rischi sistemici, come l’impatto ambientale e l’erosione dei processi democratici. In contrapposizione, il saggio propone un cambio di paradigma verso un “costituzionalismo algoritmico sostanziale”.

ABSTRACT [IT]: La nota esamina criticamente una recente pronuncia della sezione giurisdizionale del C.G.A. per la Regione Siciliana, con la quale, sul solco delle più recenti pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato, si tende ulteriormente e sempre di più a differenziare la configurazione dei consiglieri laici del C.G.A. da quella dei consiglieri laici del Consiglio di Stato, ivi compresi quelli nominati per la provincia di Bolzano, con evidenti effetti “isolazionistici” della giustizia amministrativa in Sicilia, che verosimilmente nessuna ragionevole base hanno nell’art. 23 dello Statuto della Ragione Siciliana e nelle disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana, che riguardano la giustizia amministrativa.

ABSTRACT [IT]: l’articolo esamina la “specialissima” configurazione normativa, di attuazione statutaria, amministrativa e giurisprudenziale, dei nove consiglieri “laici” del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, organo composto da due sezioni regionali (e staccate) del Consiglio di Stato in Sicilia, nell’ambito del complessivo ordinamento della giustizia amministrativa e, in particolare, di quello della magistratura amministrativa, per metterne in luce l’evidente disparità di status e di trattamento economico rispetto a quelli dei consiglieri di Stato “ laici”, perché di nomina governativa, ivi inclusi i due nominati per la provincia autonoma di Bolzano; e per verificare se questa palese differenziazione possa avere fondamento e compatibilità costituzionale, riflettendosi, in definitiva, la configurazione dei suoi consiglieri laici sul fondamento e sulla compatibilità costituzionale dello stesso Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e sull’esercizio delle funzioni, esclusivamente statali, giustiziale e giurisdizionale amministrative superiori e di ultimo grado in Sicilia.
Monografie



Il controllo sui magistrati
Vigilanza ministeriale, C.S.M.,
procedimento disciplinare
e garanzie costituzionali
Chiarezza, omogeneità e retroattività della legge
La funzione della pena e le garanzie dei diritti fondamentali
Lo studio affronta fondamentalmente tre questioni e cioè: se esista o meno, al livello costituzionale, un principio o una norma che obblighi il legislatore ad abrogare, modificare o integrare solo "espressamente" una disciplina già contenuta in un codice o in un testo unico o comunque in un corpus normativo organico; se sussista l'obbligo per il legislatore di esercitare la funzione legislativa in modo tale da produrre leggi "chiare", "semplici" e soprattutto "omogenee" per quanto attiene alle materie regolate; se esista il divieto per il legislatore di produrre norme con efficacia retroattiva anche al di fuori dell'ambito penale. Una corretta valorizzazione di principi costituzionali, unanimemente affermati e riconosciuti da dottrina e giurisprudenza, avrebbe consentito di porre, già da tempo, poderosi argini alla mai dismessa tendenza del potere politico di agire con irrazionalità ed arbitrio nella disciplina dei rapporti sociali. L'incapacità del legislatore repubblicano di vestire i panni del revisore costituzionale e la timidezza della giurisprudenza costituzionale hanno, invece, impedito di porre termine all'incertezza che ha caratterizzato il dibattito sulle tematiche oggetto del presente lavoro e di adeguare il dettato costituzionale alle esigenze di una moderna forma di Stato autenticamente liberale e democratica.
L'attenzione ai profili costituzionali della pena rappresenta l'occasione per una riflessione sistematica sulla forma di Stato e per verificare la possibilità di conciliare costantemente opposte esigenze, radicate tutte all'origine del patto costituzionale. Appare adeguato il richiamo all'immagine della bilancia quale emblema della giustizia e del diritto, perché si tratta di misurare il peso relativo di ciascun interesse, di quello alla tutela dei beni inviolabili dei cittadini dalle aggressioni criminali e di quello dei condannati a non vedere compromesse oltremodo le loro libertà fondamentali di uomini. Si tratta appunto, di tenere in equilibrio i due piatti della bilancia.
Il recente procedimento disciplinare a carico di un ex componente togato del C.S.M., conclusosi in primo grado con sentenza della Sezione disciplinare che ne ha disposto la rimozione dalla magistratura, ma anche il successivo pronunciamento del plenum del C.S.M., che ha dichiarato la cessazione dalla carica, a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, di uno dei suoi membri togati più in vista, nonché l'esito delle ultime elezioni del comitato direttivo centrale dell'A.N.M., sono tutti episodi che hanno acceso i riflettori su alcune questioni tecnico-giuridiche di grande interesse, senz'altro note, ma non sempre oggetto di specifica attenzione da parte della dottrina gius-pubblicistica: il «correntismo» nella magistratura, ossia la presenza e l'influenza di «partiti in toga» (Ainis) nell'attività «associativa» dell'A.N.M., ed in quella di rilievo costituzionale del C.S.M. e della sua Sezione disciplinare; i rischi di «isolazionismo» o di «separatezza» dell'«ordine» giudiziario dall'ordinamento giuridico democratico e unitario repubblicano e, soprattutto, dalla stessa sovranità popolare; il timore, già avvertito dai Costituenti nel 1947, che la magistratura potesse divenire, progressivamente, «un corpo chiuso, una corporazione, un mandarinato» (Ruini), arroccata in una «torre d'avorio» (Persico). Lo studio prende le mosse dall'analisi critica della potestà di vigilanza del Ministro della Giustizia, prosegue con una riflessione, sempre critica, sulla natura di «giudice» e di «giudice speciale» della Sezione disciplinare del C.S.M., provando a chiarire, in via preliminare, la posizione costituzionale, la natura giuridica e la funzione dello stesso C.S.M., che tende sempre di più a caratterizzarsi quale organo «di indirizzo politico», tramite l'uso di «auto-attribuiti» e precari poteri para-normativi. Gli esiti dell'indagine conducono a dubitare della pretesa «configurazione giurisdizionale» del procedimento disciplinare, che sembra realizzare, in realtà, una forma di autodichia «impropria», ovvero l'esercizio di un potere disciplinare «dei magistrati sui magistrati», parzialmente «incontrollato» o, al contrario, significativamente «auto-controllato», che finisce per accentuare quei rischi di «autoreferenzialità» dell'«ordine» giudiziario, già segnalati dai Costituenti, inconciliabili con l'ordinamento democratico ed unitario repubblicano e con lo stesso concetto di Stato di diritto, quale aspetto essenziale dello Stato democratico-pluralista, per la garanzia dei diritti fondamentali.